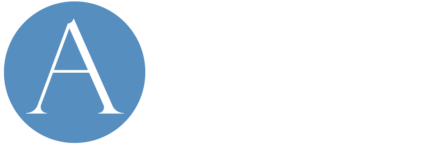Cecil Grayson
LEON BATTISTA ALBERTI: VITA E OPERE
Estratto da C. Grayson, Studi su Leon Battista Alberti, a cura di P. Claut, Firenze, Olschki, 1998 (Ingenium; 1), pp. 419-433, pubblicato per la prima volta in Leon Battista Alberti, Catalogo della mostra (Mantova, 10 settembre – 11 dicembre 1994), a cura di J. Rykwert – A. Engel, Milano, Olivetti-Electa, 1994, pp. 28-37.
Battista Alberti nacque a Genova il 14 febbraio 1404 e due circostanze sfavorevoli pesarono sulla sua giovinezza: era il secondo figlio naturale di Lorenzo e Bianca Fieschi, già vedova di un Grimaldi, e il padre era stato bandito da Firenze nel tardo Trecento con gran parte degli Alberti. La nascita illegittima e le conseguenti difficoltà familiari crearono a Battista e al fratello Carlo (1403), problemi economici e sociali che durarono oltre il 1428, quando gli Alberti furono riammessi in patria. In età avanzata Battista diceva di Firenze: «Raro ci venni e poco ci dimorai». Nondimeno rimase molto legato a quella città, come vedremo in seguito, e ai parenti, che, dopo la morte del padre nel 1421 a Padova, non volevano riconoscere i suoi diritti ereditari né favorire le sue ambizioni culturali contrarie ai loro interessi soprattutto commerciali, che avevano reso famoso il nome Alberti non solo in Italia ma in tutta l’Europa.
Questa situazione spiega la sua formazione intellettuale, direi quasi interregionale, lontano da Firenze, e in parte quella impronta pessimistica evidente in specie, ma non soltanto, nelle prime opere, e l’affinità con gli scritti satirici e amari del greco Luciano, che per primo in Europa Alberti imitò in latino nelle sue Intercoenales e nel Momus. Dall’altra parte quella situazione familiare avrebbe rafforzato, forse per reazione, una sua determinazione innata di distinguersi nelle lettere e in altre attività diverse, volte a illuminare la vita umana e ad arricchire e abbellire il suo ambiente sociale. Vi è, senza dubbio, una vena pessimistica persistente nell’Alberti, ma essa coesiste in lui con una motivazione positiva ancora più forte, senza la quale non avrebbe creato le opere letterarie, scientifiche e architettoniche che lo distinguono come uno dei più grandi ingegni del Quattrocento.
Si sa pochissimo dei suoi primi studi, svolti prima a Venezia, dove il padre si trasferì per esercitare il commercio, e poi (1415-18) nella scuola dell’umanista Gasparino Barzizza a Padova, ove avrebbe conosciuto Francesco Barbaro e il Panormita, e studiato non solo latino, ma anche greco (col Filelfo). Da Padova passò a Bologna per conseguire la laurea in diritto canonico, ma durante questo periodo gli morì il padre con le conseguenze indicate sopra, e con l’interruzione degli studi dovuta a ragioni economiche e di salute. L’avvenimento è di capitale importanza non soltanto per motivi sentimentali, ma per ragioni culturali, perché, come dice l’Alberti stesso nella sua autobiografia, si diede allora a studiare matematica e fisica come materie che richiedevano minori sforzi della memoria. Era a quel tempo probabilmente a Padova, e seguiva tra l’altro lezioni sull’ottica.
Comunque risale a quegli anni la base della sua formazione scientifica, senza la quale non sarebbe stato quella figura rara nel Quattrocento delle «due culture», cioè umanistica e insieme scientifica. Anche se tornò agli studi bolognesi, laureandosi in diritto canonico nel 1428, quella esperienza padovana dovette rimanere sempre con lui e con ciò spiegare fin dagli anni Trenta quell’elemento matematico che sottende le sue opere sulla prospettiva (De pictura), sulla topografia (Descriptio urbis Romae), sull’architettura, e magari tutta la sua visione della vita e del mondo come creazione ordinata da Dio. Ma questa tendenza scientifica non compare nelle prime opere di Battista, che sono tutte letterarie, sebbene vi appaia già il concetto dell’uomo padrone della propria sorte e quella fede nello spirito umano nutrito dalle buone lettere e capace di resistere all’avversa fortuna, che saranno temi costanti dell’Alberti scrittore: una commedia latina, Philodoxeos(1424), uno studio De commodis litterarum atque incommodis (1428-29) nel quale espone le difficoltà (sue e comuni) di chi sceglie, con molta fatica e poco reddito, la vita dello studioso; e le prime Intercoenales (prima del 1430) con molte allusioni alla propria sorte di orfano.
Secondo le informazioni della sua autobiografia, scrisse allora anche in volgare prose e versi di argomento amoroso con evidenti riferimenti personali: due dialoghi, Deiphira ed Ecatonfilea, che per il tema e lo stile richiamano le opere minori del Boccaccio (e furono tra le poche opere dell’Alberti stampate nel Quattrocento), e un gruppo di poesie notevoli per la loro forza espressiva e la varietà metrica. In senso più largo è pure notevole questa ripresa (accanto al consueto latino umanistico) delle tradizioni letterarie toscane da parte di uno scrittore allevato fuori della Toscana, che si dimostra, malgrado l’esilio, capace di usarne bene la lingua.
Più tardi, sottomettendo la sua più nota opera sulla Famiglia al giudizio di amici (e anche nella sua autobiografia), farà riferimento a questa sua «mancanza» ma sarà in un clima diverso, quando con grande vigore si farà campione e promotore del volgare come mezzo capace di esprimere, non meno del latino, le materie più serie. Negli anni dei primi tentativi volgari, prima del ritorno a Firenze, rimaneva entro i limiti tradizionali dell’idioma moderno; la sfida all’antico verrà dopo con importanti conseguenze per la lingua e la letteratura italiana.
Grazie all’intervento di papa Martino V, il bando agli Alberti fu levato nel 1428, e (a giudicare dalle osservazioni sulla società fiorentina nel citato De commodis) allora Battista tornò seppure brevemente a Firenze. Mancano purtroppo documenti per gli anni 1428-31, quando, secondo alcuni biografi, egli entrò al seguito del cardinal Albergati, accompagnandolo nella sua missione per la pace di Arras. Prova ne sarebbero taluni riferimenti nel De re aedificatoria (1452) a metodi di costruzione seguiti all’estero; ma non si può essere sicuri che li abbia visti coi propri occhi. Nell’autobiografia non accenna a tali viaggi. Una cosa invece è certa, cioè la soluzione del problema della carriera affrontato nel De commodis; si fece sacerdote (flamen) e a Roma diventò segretario di Biagio Molin, patriarca di Grado che lo fece nominare abbreviatore apostolico. Così entrò nel gruppo distinto di umanisti al servizio del papa Eugenio IV, che lo assolse dal difetto della illegittimità e lo nominò (1432) al beneficio di San Martino a Gangalandi (Lastra a Signa) vicino a Firenze, che godette fino alla morte. Visitava la chiesa quando poteva (ma soprattutto nel periodo 1434-42, durante il soggiorno della corte papale a Firenze), e comunque lasciandovi buona memoria di sé e notevoli ricordi architettonici nella fabbrica della chiesa. Diventò anche canonico del duomo di Firenze. In seguito ebbe altri benefici, a Borgo San Lorenzo (1448) e infine a Bagno a Ripoli. Pur essendo così legato ecclesiasticamente a Firenze, non aveva obblighi di residenza; la sua presenza si sarà limitata a visite più o meno lunghe.
Dal 1431 la sua dimora stabile era Roma, dove gli incarichi assunti gli offrivano la desiderata libertà economica e intellettuale. È impossibile dire se avesse a quella data e poi una vocazione spirituale. La religione entrerà certamente nei suoi scritti, e nel suo concetto della Natura e dell’uomo, posto in vita per servire Dio e ammirare e ricreare il Suo universo. Nelle opere non parla mai di Cristo; l’uomo stesso provvederà semmai alla propria «redenzione» in questo mondo conducendo una vita utile a sé e agli altri: «bene et beate vivere» ciceroniano predomina nel pensiero dell’Alberti. Tutto ciò non esclude la fede in Dio, ma la concepisce nei termini umanistici della prima metà del Quattrocento. Basta leggere la sua Vita S. Potiti, scritta per Biagio Molin intorno al 1433, per intendere l’atteggiamento dell’Alberti davanti alle tradizioni ascetiche medievali in confronto con le rinnovate idee precristiane dell’uomo attivo che non pensa di rinunciare al mondo ma di intenderlo e goderlo. Proprio tra il 1433 e il 1434 egli stese a Roma in novanta giorni (secondo l’autobiografia) i primi tre libri Della famiglia in volgare, l’opera più luminosa sull’argomento, non solo del Rinascimento, ma di tutta la letteratura italiana. Malgrado le difficoltà personali coi parenti, il giovane Alberti indirizza a loro questa sua opera, che in forma di dialogo tratta l’educazione dei figli (I), l’amore e le cose che rendono e mantengono felice una famiglia (II), e la masserizia (III); a questi tre libri infine, intorno al 1440, ne aggiunse un quarto sull’amicizia.
Per uno che non ebbe mai né moglie né figli, e aveva espresso già e continuò a esprimere un forte misoginismo, è un’opera eccezionale, fondata sulla propria esperienza e sulla storia della «famiglia Alberta», ivi celebrata, e in gran parte sulla conoscenza della letteratura antica – un felicissimo amalgama di precetti e pratiche antiche e di esperienze moderne, prettamente umanistico nel senso che mira alla formazione e alla felicità dell’uomo. Movendo dalla convinzione che gli uomini sono responsabili della propria sorte, insegna le vie della virtù «sufficiente a conscendere e occupare ogni sublime ed eccelsa cosa, amplissimi principati, suprema laude, eterna fama e immortal gloria», contro cui è invalida la fortuna.
Questo concetto della virtù come realizzazione della naturale armonia insita nell’uomo, come operosità opposta all’ozio e come conquista del volere e della ragione ricorre qui e dappertutto nelle opere morali dell’Alberti, e costituisce il fondamento della sua ‘filosofia’ e della sua religione. Gli servono qui, come in altre opere, diversi scrittori greci e romani, di cui dimostra già una larga conoscenza; e con essi e con l’esperienza personale mira soprattutto a riuscire utile – anche questo un motivo principale di tutta la sua vita. Mai esistono in lui come fini a se stessi lo studio e l’erudizione, ma sempre come mezzi per arricchire e migliorare la vita umana, sia negli aspetti morali che in quelli pratici. Questo fondamentale atteggiamento spiega anche, come vedremo, la sua promozione del volgare.
A quei primi anni romani risalgono pure i suoi primi contatti con artisti e l’esame degli antichi resti architettonici di Roma. Nell’autobiografia allude anche a certi esperimenti ottici con una specie di camera oscura che stupivano gli amici, e con uno strumento geodetico di sua invenzione cominciava a prendere le misure della città, che figureranno nella sua Descriptio urbis Romae. Insomma, già all’età di trent’anni dava prova di quella versatilità di interessi letterari e scientifici che lo distinguono dagli intellettuali del tempo.
Era perciò ben preparato per l’incontro con Firenze negli anni 1434-42, quando la curia vi andò per il Concilio delle chiese romane e greche dopo un breve soggiorno, interrotto dalla peste, a Ferrara (dove l’Alberti avrà conosciuto gli Estensi). Avrà forse assistito alle discussioni amministrative e teologiche, ma non ne rimangono tracce nelle sue opere (a differenza di quelle di altri, come Poggio o Valla); maggiore impressione gli fece l’incontro col mondo artistico fiorentino, con Brunelleschi, Ghiberti, i Della Robbia, Donatello, Masaccio, anche se forse ne aveva già conosciuto alcuni in visita a Roma.
Compose allora il De pictura (1435) in latino, con una dedica a Giovan Francesco Gonzaga, mentre dedicò la successiva edizione in volgare (1436) al Brunelleschi con una lettera piena di lodi della nuova cupola del duomo e dello stupendo risveglio artistico fiorentino. Basato in parte su fonti antiche (in specie Plinio) e forse su recenti esperimenti prospettici del Brunelleschi, su lavori di artisti fiorentini e sulle proprie esperienze dell’arte pittorica (menzionate in termini generici nell’autobiografia) questo trattato in tre libri – il primo in materia dell’era moderna – è notevolissimo per l’applicazione della matematica alla rappresentazione «reale», prospettica della natura, e per l’alto concetto dell’artista non come fabbro ma «quasi un altro iddio», cioè osservatore e ricreatore dell’universo. Vi si insegna non solo a rappresentare sulla tavola piana la ‘storia’, vista o immaginata, a tre dimensioni, con corrette proporzioni e relazioni tra le figure e l’ambiente, ma anche come usare luci e ombre e colori, e come scegliere la materia dall’arte affine della parola, cioè dalla letteratura.
Come già detto, fece due versioni della Pittura, l’una per gli eruditi, l’altra per gli artisti. Quasi subito dopo e con evidente richiamo a un dibattito avvenuto nel 1435 a Firenze tra i segretari apostolici e ricordato da Flavio Biondo nel suo De locutione romana, l’Alberti stese una lettera dedicatoria a Francesco d’Altobianco Alberti del libro III della Famiglia, nella quale spiega e difende il suo uso del volgare in quell’opera. Nella disputa intorno al latino del 1435 figuravano due opposte teorie: che Roma antica avesse due lingue, latino e volgare (situazione analoga a quella del Quattrocento); che Roma antica avesse una sola lingua in diverse forme, il latino «classico», raffinato e regolare, e il latino diciamo popolare di uso comune. Il Biondo, fautore di quest’ultima teoria, sosteneva inoltre che la presente lingua volgare d’Italia discendeva dal latino, corrotto dall’uso specie dopo la caduta dell’Impero e poi dalle invasioni di eserciti e lingue straniere.
Nella suddetta lettera l’Alberti, senza nominarlo, condivide le idee del Biondo (sono i primi segni di una nuova teoria delle origini delle lingue romanze), ma va molto oltre, giustificando l’uso del volgare non solo con motivazioni storiche ma con argomenti di utilità e della sua perfezionabilità. Basta che i letterati si esprimano in volgare, che è capace di fare intendere qualunque materia e a più numerosi lettori. L’Alberti aveva già dimostrato nella Famiglia, e dimostrerà in altre sue opere, questa capacità della moderna lingua, ricorrendo, per riparare alle sue mancanze sintattiche e lessicali, alla lingua madre, il latino. Umanista e latinista, egli per primo si libera con la teoria e la pratica dal secolare pregiudizio contro il volgare che in passato l’aveva escluso dalla trattazione di materie serie.
Non stupisce perciò sapere che l’Alberti stese la prima grammatica del volgare, della «nostra oggi toscana» (forse intorno al 1442), il cui proemio in poche parole echeggia la dedica al libro III della Famiglia. Essa mostra la regolarità del toscano, conforme alle categorie grammaticali del latino, e non si appella a esempi letterari, ma si riferisce all’uso della regione. Notevole dunque qui non solo la novità ma la mancanza di qualunque richiamo alla tradizione letteraria, o di pregiudizi geografico-linguistici, a differenza delle grammatiche cinquecentesche, che precede di settant’anni. A questo orientamento corrisponde il carattere della prosa albertiana, di base toscana, ma variamente infarcita di latinismi e non priva di settentrionalismi. Precursore del Landino e di Lorenzo de’ Medici, del Fortunio e del Bembo in questo settore, anticipava anche il Trissino proponendo nella sua grammatica anche riforme ortografiche.
II pensiero dell’Alberti moveva dalla convinzione che, pur essendo erede della ricca, rinnovata antichità, l’uomo può ancora trovare, come scriveva al Brunelleschi, «arti e scienze non udite e mai vedute». Percio non si mostrò mai servile né puro imitatore della scienza antica, ma se ne servì per andare oltre, per ampliare le conoscenze umane. Donde la straordinaria varietà delle opere composte o terminate negli anni 1435-43 oltre a quelle già accennate: sull’amore e il matrimonio (Sofrona e Uxoria), sulla giustizia (De iure), sulle virtù e i doveri del vescovo (Pontifex), sull’agricoltura (Villa), sull’amicizia (libro IV della Famiglia); poi un gruppo di Apologi latini e altre Intercoenales, due opuscoli pur lucianeschi tra faceto e serio, Musca e Canis, e due importanti dialoghi morali in volgare, Teogenio e Profugiorum ab aerumna libri.
Fece allora alcune scappate da Firenze a Bologna, Ferrara e Perugia, e organizzò nel 1441 a Firenze con l’aiuto di Piero de’ Medici un concorso poetico, il «Certame coronario», in volgare, sul tema dell’amicizia – avvenimento storico, linguistico, letterario assai significativo se non tanto ben riuscito, che s’inquadra nelle altre iniziative dell’Alberti come promotore della moderna lingua. Per l’occasione egli compose sull’amicizia sedici esametri (latini) in volgare, il primo tentativo (di una lunga serie fino al secolo XIX) di adattare i metri antichi alla poesia italiana.
Sull’argomento della lingua l’Alberti tornò ancora poco più tardi nella dedica del Teogenio a Leonello d’Este, respingendo le accuse che faceva male a scrivere in volgare di materia così importante, e insistendo di nuovo sull’utilità del volgare. La materia in questione, come pure nei citati Profugiorum ab aerumna libri dello stesso periodo, era di carattere morale: l’Alberti vi insegna come affrontare e vincere i rovesci della fortuna e le ingiurie del mondo. Questi dialoghi, scritti secondo l’autore per consolarsi nelle «avverse fortune», sembrano col loro stoicismo indicare una crisi nella vita e nel pensiero suo. È difficile sapere quali fossero queste avversità negli ultimi anni del soggiorno fiorentino.
Comunque sia, il ritorno a Roma nel 1443 apre una nuova stagione nei suoi interessi e attività; cominciano a prevalere quelli scientifici e artistici già evidenti a Roma e Firenze. Cade qui a proposito menzionare un opuscolo scritto per Leonello d’Este dopo una visita a Ferrara nel 1441, il De equo animante. Invitato come arbitro in un concorso di artisti per un monumento equestre a Niccolò III d’Este (di cui mancano ora le tracce fuori del cosiddetto arco del Cavallo), l’Alberti scrisse il breve trattato, che, basato su fonti antiche e moderne, greche, latine, italiane, e perfino arabe, pur risulta eccezionale sullo sfondo di una tradizione preminentemente veterinaria. Partendo dal cavallo nella storia e dalla descrizione della forma e delle qualità, scrive sull’allevamento e sul maneggio dei cavalli, su alcune malattie e rimedi, per insistere poi sulle funzioni del nobile animale in pace e in guerra, come aiuto e ornamento della vita umana. Insomma ha tutte le caratteristiche dell’umanesimo albertiano, non solo per la varia erudizione, ma per tutto il modo di trattare la materia – umano, storico, artistico, pratico.
L’Alberti racconta nell’autobiografia che i più fieri cavalli tremavano quand’era in sella; così montato faceva straordinarie manovre. Queste e altre prodezze fisiche sue si leggono in un profilo delle sue qualità morali e pratiche che tende all’esagerazione; il che si spiega con la forma inconsueta di questa biografia, creduta per lungo tempo anonima, perché scritta in terza persona. Solo all’Alberti poteva venire allora in mente l’idea di scrivere di sé come fosse un altro. Perfino gli obiter dicta ricordati nella conclusione sono modellati sulla forma delle vite antiche degli uomini famosi, e tutto il tono è, come in tante altre sue opere, tra il serio e il faceto; sarà in un certo senso uno scherzo, ma contiene informazioni solide sulle sue vicende e attività personali che solo lui poteva conoscere e commentare. Oramai riconosciuta come autobiografica, questa vita costituisce un altro singolare documento della sua originalità, prezioso per il ritratto e i particolari personali fino alla prima metà del 1438. Purtroppo non va oltre quella data, a giudicare dalle opere sue citate nel testo, e perciò non serve a illuminare le «avverse fortune» menzionate sopra, né a illustrare la seconda metà della sua vita a cui ora ci rivolgiamo.
Nel giugno del 1443 la corte papale tornò a Roma. Gli esempi di frasi citate per illustrare i tempi del verbo fanno ritenere che l’Alberti abbia composto allora la grammatica toscana, la cui ideazione risalirebbe al soggiorno fiorentino. Ma negli anni seguenti, e soprattutto dopo l’elezione al papato del suo vecchio amico Tommaso Parentucelli di Sarzana (Nicolò V) nel marzo del 1447, le sue energie sembrano volgersi a questioni pratiche: la misurazione della città e la stesura della Descriptio urbis Romae, accompagnata forse da un disegno topografico andato perduto; il restauro di edifici, fontane e acquedotti, progettati da Niccolò V, e il tentativo (riuscito) di salvare, per mezzo di botti flottanti, un nave romana affondata nel lago di Nemi. A quest’ultimo parrebbe riferirsi il trattato Navis, ricordato dall’autore nel De re aedificatoria, ma ora perduto.
Intanto si preparava con l’esame degli edifici romani superstiti e soprattutto con la lettura, di Vitruvio a stendere il suo trattato architettonico, che portò a termine entro il 1452. A questa data aveva già avuto la sua prima commissione come architetto dal governatore di Rimini, Sigismondo Malatesta, cioè il rifacimento esterno della chiesa di San Francesco, che sull’architrave porta la data del 1450 (uguale a quella della medaglia commemorativa di Matteo de’ Pasti), ma i lavori continuarono dopo quella data senza mai essere completati, interrotti forse nel 1454, quando in una famosa lettera al Pasti l’Alberti dava direttive sulla costruzione del tetto e della parte superiore della facciata. Perfino oggi rimane in quello stato incompiuto, anche se è ormai chiaro da quella lettera che l’Alberti voleva mettere sul timpano certe volute simili a quella che metterà poi sulla facciata di Santa Maria Novella a Firenze. Ma anche senza quelle, la chiesa, nota come il Tempio Malatestiano, è giustamente famosa per il suo disegno classicheggiante.
Rivestendo di marmo l’antica costruzione medievale, l’Alberti si ispirava per la facciata all’arco trionfale, e per i lati agli archi continui del Colosseo, in cui collocava le tombe di uomini famosi alla corte di Sigismondo. In tutto ciò sono fondamentali le proporzioni delle parti e dell’insieme. Nella lettera citata l’Alberti obietta che le proposte del Pasti per la facciata guasterebbero «la musica», cioè l’armonia strutturale fondata sugli intervalli numerici musicali. Tale concetto, presente nelle costruzioni antiche e in Vitruvio, si ripeterà nelle teorie e negli edifici ideati dall’Alberti. Se sorgevano in questo caso problemi strutturali era perché doveva adattare il suo nuovo disegno alla costruzione esistente. Nella carriera successiva egli dovette affrontare difficoltà analoghe. Ma a Rimini non solo strinse molte nuove amicizie (ad esempio con Agostino di Duccio, responsabile con Pasti della straordinaria decorazione interna della chiesa), ma si fece una reputazione come architetto, rafforzata anche dalla composizione del De re aedificatoria che gli assicurò importanti committenze in altre città d’Italia.
Tutte queste, quella di Rimini inclusa (almeno in parte), sono posteriori al suo trattato d’architettura, che per forza dipende dallo studio di testi ed edifici più che dall’esperienza di lavoro. Ma ciò non toglie la coerenza del teorico e dell’architetto praticante. Certo l’Alberti era un letterato e non un costruttore di mestiere; per formazione e per disposizione mentale era naturalmente portato allo studio dei documenti e dei princìpi dell’architettura più che alla tecnica edificatoria, senza la quale non si costruisce niente. II suo trattato rispecchia questa attitudine; è l’opera di un letterato, ma anche di uno che sapeva il fatto suo. Con esso nasce un concetto nuovo dell’architetto, ideatore di costruzioni rispondenti ai bisogni dell’uomo e alle proporzioni insite nella Natura creata da Dio, e dirigente dei lavori che le realizzano. D’ora in poi non sarà più il «fabbro», spesso anonimo, dei secoli passati. Col De re aedificatoria si apre l’era moderna dell’architetto colto, analogo al ruolo assegnato dall’Alberti al pittore nel De pictura.
Il trattato si basa sull’opera di Vitruvio, conosciuta durante il Medioevo e nata a nuova vita nella cerchia romana di Poggio come manuale dell’antichità archeologica. Con l’Alberti invece il libro di Vitruvio ritorna alle sue funzioni originali, come descrizione e insegnamento dei princìpi e dei metodi dell’architettura antica, i quali erano rimasti trascurati per molti secoli. Non si tratta di traduzione, ma di assimilazione e ripresentazione dei criteri e delle forme della storia dell’arte antica greco-romana. Perciò l’opera albertiana, seguendo le tracce di Vitruvio, svolge una teoria dell’architettura fondata su proporzioni pitagorico-platoniche inerenti all’ordine della Natura, che costituiscono princìpi perenni di armonia e bellezza. Per l’Alberti l’architettura è l’arte più vicina all’uomo: «a necessitate profecta est; eam aluit commoditas; usus honestavit; ultimum fuit, ut voluptati prospiceretur, tametsi nunquam ab immodicis omnibus voluptas non abhorruit». Arte dunque utile, secolare, sociale, e bella, necessario e degno ricovero e ambiente dell’uomo, e specchio dell’interna armonia della sua mente e del suo corpo. Qui tocchiamo l’intima coerenza tra l’Alberti scrittore morale e l’Alberti teorico dell’architettura e creatore di edifici corrispondenti a questi ideali. Simili princìpi erano destinati a prevalere nel mondo architettonico per quasi quattro secoli.
Il De re aedificatoria è diviso in dieci libri che trattano rispettivamente: I, Dei disegni, della situazione, e di alcuni particolari degli edifici (colonne, finestre, archi, scale); II, Dei materiali di costruzione; III, Dei princìpi della costruzione; IV, Degli edifici per uso pubblico; V, Degli edifici di diverse persone private; VI, Degli ornamenti delle fabbriche; VII, Della costruzione dei templi; VIII, Degli ornamenti delle vie principali, dei sepolcri e di altri luoghi pubblici; IX, Degli ornamenti delle case private, e delle qualità e conoscenze necessarie all’architetto; X, Delle acque, dei canali, delle vie, e di vari metodi di rimediare ai guasti agli edifici dovuti al tempo e alle bestie.
Questo nudo elenco del contenuto indica la sostanza e la varietà della materia trattata. Inoltre l’opera riporta molte superstizioni, miti, aneddoti e storielle relative all’architettura; sono le parti più letterarie, forse non assolutamente necessarie, ma spesso divertenti. Nulla tolgono all’importanza e influenza di questo primo trattato moderno in materia, sul quale a lungo poggiò la fama dell’Alberti – e non soltanto perché l’essere stampato gli diede migliore fortuna dei molti suoi scritti rimasti per secoli inediti.
Nello stesso torno di tempo compose e dedicò a Meliaduso d’Este un opuscolo intitolato Ludi rerum mathematicarum (prima del 1452), che dà regole per misurare la superficie dei terreni, le altezze di torri, la profondità di pozzi, la distanza tra città, ecc.; materie affini, cioè, a certi aspetti del trattato d’architettura e anche ai metodi trigonometrici della Descriptio urbis Romae. Un’altra opera affine, in data incerta, ma sicuramente di questo secondo periodo della sua vita, sarebbe il De statua, che descrive metodi e strumenti per misurare il corpo umano e così poter rappresentarlo a tre dimensioni nello spazio. Sappiamo che s’interessava di scultura, e quasi certamente è di sua mano la testa di Lodovico Gonzaga (Berlino), come pure la propria effige su medaglia (Washington), se non anche quella di Parigi, tutte e tre in bronzo. Ma in mezzo a questo fervore artistico non trascurava la letteratura.
Oltre al De Porcaria coniuratione (1448-49), scrisse prima del 1450 in prosa latina una delle sue opere più enigmatiche intitolata Momus, una mordente satira lucianesca del principe e in genere delle vanità e debolezze di tutti gli uomini. Al centro della favola mitologica è il dio ribelle Momo, che mette in scompiglio uomini e dei, scoprendo in specie l’incompetenza del sommo Giove. Nella grottesca e complicata esagerazione del racconto gli strali della satira non risparmiano nessuno; si salvano forse soltanto il mendicante, privo di cure e di responsabilità, e l’architetto chiamato da Giove a preparare un piano per la riforma del mondo.
Si sospettava allora che Momus fosse una satira contro Eugenio IV (Giove), ma mi sembra piuttosto una caricatura spassosa di uomini e dei, di un mondo più capace in terra che in cielo; donde la responsabilità dell’uomo sulla propria sorte scissa da qualunque direttiva celeste; insomma una visione della confusione e impenetrabilità di un piano universale, a cui l’uomo stesso deve rimediare. Sembra nella sua presentazione il rovescio del mondo ordinato delle precedenti opere morali, ma non lo è; è una favola scherzosa che pure porta lo stesso messaggio della responsabilità dell’uomo virtuoso e operoso; divertente ma utile attribuire al cielo lo stato e la causa del disordine che sembra regnare sulla terra.
La stesura del Momus appartiene agli anni in cui Alberti attendeva soprattutto a progetti architettonici, dove regna tutt’altro che disordine. Gli si attribuisce ad esempio il piano per la ricostruzione del Borgo Leonino descritto dal Manetti, perché i particolari indicati corrispondono alla descrizione, nel libro IV del De re aedificatoria, della pianificazione urbana (vie, piazze, edifici, attività commerciali, ecc.); donde poi l’attribuzione all’Alberti (ormai inattendibile) anche del dipinto La città ideale nel palazzo ducale di Urbino. Il progetto voluto da Niccolò V non fu realizzato; ma come progetto albertiano s’inserisce bene nella serie di lavori fatti per quel papa e indicati dal Vasari, che sarebbero terminati con la morte di Niccolò nel 1455.
Da quest’anno in poi per più di un decennio Alberti eseguì importanti lavori per un ricco cittadino fiorentino, Giovanni Rucellai. Primo in ordine cronologico pare sia stato palazzo Rucellai in via della Vigna a Firenze, l’unico edificio civile disegnato dall’Alberti (se si esclude palazzo Venezia a Roma, di dubbia attribuzione) e costruito prima del 1460. Si distingue da altri palazzi fiorentini quattrocenteschi per l’assimilazione di certe caratteristiche architettoniche romane all’esterno e all’interno. Sulla facciata a tre piani distinti da due architravi sono tre ordini di pilastri decorativi, di cui l’inferiore è dorico, i superiori misti. Le finestre bifore dei piani superiori, sono sormontate da archi a tutto sesto, decorati da rilievi tondi e semitondi. In cima alla facciata un ampio cornicione. All’interno si trova un ampio cortile con un portico intorno sostenuto da colonne corinzie. Tale assimilazione di elementi romani in un edificio laico servì da modello per altre simili costruzioni civili, ad esempio il palazzo fatto costruire da Pio Il a Pienza.
L’iscrizione sulla facciata di Santa Maria Novella porta la data 1470, ma la commissione del Rucellai risale al 1457-58. Si trattava di completare la facciata, di cui era già stata fatta un secolo prima soltanto la parte inferiore, con le sue tre porte e le sei nicchie con tombe, in quel vecchio stile bianco e nero simile, ad esempio, al battistero. La soluzione albertiana ai problemi stilistici e strutturali è brillante. Tutta la facciata starebbe in un quadrato, e le sue tre parti rappresenterebbero ciascuna esattamente un quarto del quadrato; cioè la parte superiore all’architrave è uguale a metà della parte inferiore divisa verticalmente in due. Insomma il rapporto è di 1:2, in termini musicali un’ottava. Per quanto riguarda la struttura, l’Alberti vi ha provveduto con un profondo attico e un timpano di stile classico, collegati da grandi volute, che nascondono completamente la fabbrica della vecchia chiesa (cfr. l’analogo problema del Tempio Malatestiano).
Nell’iscrizione sulla facciata, come pure sul Tempio Malatestiano, abbiamo i primi esempi rinascimentali del recupero delle lettere romane geometricamente proporzionate secondo il quadrato o il circolo. Ma l’esempio più splendido di tali lettere si trova sul Santo Sepolcro nella piccola chiesa di San Pancrazio (dietro il palazzo Rucellai) costruito per il Rucellai negli anni 1462-67. E’ un vero gioiello per la sua forma, le sue proporzioni armoniche corrispondenti pure a quelle della chiesa stessa, il marmo bianco con decorazioni geometriche in verde e rosso, e poi le lettere della citazione dal Vangelo di Marco, «Yhesum queritis, [ecc.]» che si leggono intorno alla cornice. Per quanto si sappia, Alberti sarebbe stato il primo a introdurre queste lettere sugli edifici del Quattrocento, se non anche il primo addirittura a recuperarle dalle iscrizioni antiche. Comunque, da questo punto in poi diventarono di uso comune nell’architettura.
Queste committenze del Rucellai dovettero portare l’Alberti spesso a Firenze negli anni Sessanta. Frattanto accompagnò papa Pio II a Mantova nel 1459 per la Dieta, e conobbe Lodovico Gonzaga forse non per la prima volta, il quale nel 1460 gli affidò il progetto e la costruzione della chiesa di San Sebastiano, e dieci anni dopo quella di Sant’Andrea, che non vennero terminate prima della morte dell’architetto. I conseguenti problemi di eventuali interventi da parte di altri riguardano piuttosto San Sebastiano, certamente iniziato prima, e rimasto tuttora con l’aria di opera incompiuta, malgrado i restauri di quasi un secolo fa. Infatti, mentre è possibile apprezzare il piano generale della fabbrica, quadrato e in forma di croce greca, e certe proporzioni della facciata e dell’interno, si rimane tuttavia incerti su molti particolari importantissimi.
I problemi di San Sebastiano, evidenti già nei primi lavori e persistenti ben oltre la scomparsa dell’Alberti, non scoraggiarono Ludovico Gonzaga, che nel 1470 gli affidò l’ambiziosa impresa di Sant’Andrea. In quel momento l’Alberti era impegnato anche in altre cose per il marchese; a Firenze dirigeva i lavori sulla tribuna dell’Annunziata progettata dall’architetto Manetti alcuni anni prima (l’Alberti l’avrà forse modificato, ma il disegno non è suo, come in passato si credeva). Per Sant’Andrea egli propone in una lettera al Gonzaga il modello dell’Etruscum sacrum e gli manda il disegno. Purtroppo l’Alberti non è sopravvissuto ai primi lavori, ma la risultante chiesa rispecchia i suoi piani meglio di San Sebastiano. Si vedono certo delle rassomiglianze, nelle proporzioni, nella scalinata (attuata qui, ma ipotizzata per San Sebastiano), nell’architrave e nel frontone; ma il modello per la facciata di Sant’Andrea è diverso, cioè l’arco trionfale già imitato a Rimini, ma qui esemplato sull’arco di Tito a Roma e quello di Traiano ad Ancona.
Perfino in quegli ultimi suoi anni pieni di attività architettoniche continuava a scrivere; aveva almeno più libertà dopo la soppressione nel 1464 del Collegio degli abbreviatoti dovuta a Paolo II. Scrisse allora, forse nel 1467, un’opera in latino, De componendis cifris, basata sui suoi studi matematici e linguistici e sull’esperienza della curia, in cui discorre sulla crittografia e propone un suo sistema originale per la scrittura segreta, meritandosi un posto significativo nella storia di questa materia.
Come si è visto, frequentava spesso Firenze. La sua presenza come interlocutore nelle Disputationes camaldulenses del giovane amico Landino richiamava una di queste visite (1468) al gruppo intorno a Lorenzo de’ Medici. E sempre a Firenze e in questo ultimo anno è ambientata la sua ultima opera intitolata De iciarchia e composta in volgare, in cui riprende e sviluppa con maggiore maturità gli ideali di virtù moderata, già espressi nei suoi precedenti lavori. Nel dialogo tra Battista, Niccolò Cerretani e Paolo Niccolini, alla presenza dei giovani nipoti Alberti, si ragiona delle doti e dell’ufficio del principe e dell’iciarco, o cittadino primario, nella consueta tematica moralistica di equilibrio tra passioni e meditazione, tra culto degli studi e operosità civile.
L’Alberti non era un uomo politico; trent’anni prima nel libro III della Famiglia aveva messo in bocca al vecchio Giannozzo una forte sfiducia nella vita politica fiorentina; meglio stare sulle sue in famiglia lontano da tali imbrogli. Con gli anni e con l’esperienza delle corti nel De iciarchia accetta le responsabilità del buon cittadino accanto al buon principe, dotato di simili qualità morali e intellettuali. Quest’opera degli ultimi suoi anni è degna di stare accanto alla Famiglia come la somma espressione del suo pensiero morale e sociale.
L’Alberti morì a Roma nell’aprile 1472. Nel testamento datato 19 aprile volle essere sepolto in Sant’Agostino e poi trasferito nella tomba padovana del padre, ma ora non rimangono tracce sue né a Roma né a Padova. Il monumento alla sua vita sarà invece il corpus delle opere numerose e varie, forse più durature di una pietra tombale. Ancora nel testamento «reliquit iure legati, voluitque et mandavit quod cappella incepta et quasi perfecta in ecclesia Sancti Martini de Gangalandi […] perficeatur et compleatur ex et de bonus testatoris et eius hereditatis». Si trattava dell’abside evidentemente progettata ma non finita prima della morte dell’architetto priore; e doveva sostituire una sistemazione medievale. II disegno consiste in un grande arco su pilastri (con stemmi albertiani) e dentro la rientranza a mezza cupola (dove stava l’altare) un fregio sostenuto da altri quattro pilastri simili. L’aspetto è semplice e austero, simile al rifacimento dell’interno di San Pancrazio.
L’Alberti è comunemente definito l’«uomo universale» per eccellenza del Quattrocento, ma la formula è troppo generica per cogliere la ricca e complessa personalità di uomo, scrittore e architetto che si è cercato di delineare in queste pagine, e che nella sua multiforme varietà eccede i limiti delle comuni definizioni dell’Umanesimo. Per la sua universalità rimane una figura atipica della sua epoca, nonché alquanto isolata, nota a molti ma conosciuta forse da pochi nella sua intimità. Pur tra le moltissime attività e i numerosi rapporti personali sembra un uomo appartato, immerso nella continua ricerca di cose nuove. Di lui scriveva il Poliziano nella premessa alla prima edizione del De re aedificatoria (Firenze 1485): «Nullae quippe hunc hominem latuerunt quamlibet remotae litterae, quamlibet reconditae disciplinae […] cum tamen interim ita examussim teneret omnia, ut vix pauci singula». Tutta quella scienza, sia letteraria che scientifica e tecnica, è in lui coerente e interdipendente, e fondamento di una unica visione del mondo, dell’uomo e della natura.