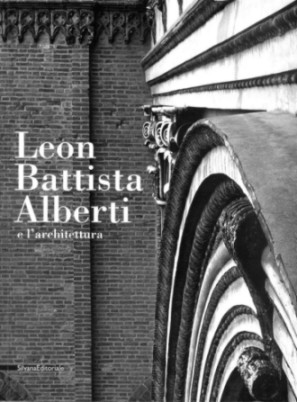Il novero di tali opere, che potrebbe risultare assai vasto, è stato limitato a quelle che sono sembrate più strettamente e giustificatamene legate alle architetture di Alberti, o perché direttamente inserite nei suoi stessi edifici, o perché portatrici di evidenti riprese figurative e di particolari soluzioni, tanto da testimoniare la prima fortuna artistica dell’architettura albertiana.
Verranno inoltre presi in considerazione numerosi disegni dei secoli XIX e XX e modelli utili a discutere l’originalità degli edifici e storicizzarne le trasformazioni, a fronte di nuovi rilievi di precisione eseguiti in occasione della mostra con la collaborazione dell’Università di Ferrara.
Luogo della mostra saranno gli ambienti della Casa del Mantegna, che si trova di fronte alla chiesa di San Sebastiano. L’ospitalità della Casa del Mantegna permette, già di per sè, di accostare la mostra a quelle che saranno contemporaneamente aperte a Mantova per illustrare l’opera del grande pittore, permettendo di rinnovare idealmente il tempo della illuminata committenza di Ludovico Gonzaga, che volle impiegare entrambi gli artisti nella loro maturità.
La mostra si apre con gli inizi di Alberti a Firenze e Roma, all’origine delle sue elaborazioni dopo le prime esperienze a Venezia, Padova e Bologna, dove pure si era scoperto studente di diritto atipico, interessato com’era a matematica e geometria. Fra le opere esposte intorno al modello antico della lanterna della cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi, la Madonna col bambino attribuita a Donatello della Pinacoteca Comunale di Prato, il rilievo in marmo della Liberazione di San Pietro dal carcere di Luca della Robbia - artisti citati da Alberti nella lettera dedicatoria del Della pittura (1436) a Filippo Brunelleschi - e un rilievo fotogrammetrico dell’affresco della Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella, opera che deve aver molto impressionato Alberti al suo arrivo a Firenze. A fronte, la veduta di Roma, dipinta nel XVI secolo sulla scorta di un prototipo del secolo precedente e conservata a Mantova (Museo di San Sebastiano, Mantova), e il calco di un riquadro della porta bronzea di san Pietro del Filarete, a testimoniare l’altra fonte delle conoscenze di Alberti. Ancora due opere di pittori che possiamo mettere in relazione con Alberti anche per il loro anticipatore interesse per l’architettura, Filippo Lippi (Madonna con Bambino, angeli, santi e donatore, Collezione Cini) e Benozzo Gozzoli (San Domenico che resuscita un fanciullo, Pinacoteca di Brera), si affiancano ad una serie di preziosi manoscritti dei trattati albertiani su pittura, scultura e architettura, ivi comprese la copia del De re aedificatoria con nota di possesso di Giulio Romano, un’inedita copia con disegni tracciati fra la fine del XV e gli inizi del XVII ad illustrare del testo di Alberti, e il manoscritto con il suo autoritratto (Roma, Biblioteca Nazionale).
La mostra segue quindi cronologicamente tutte le tappe dell’attività di Alberti architetto, da Ferrara a Rimini, Firenze, Mantova. Fra le opere principali, per Ferrara viene esposto il modello settecentesco del campanile del duomo (Ferrara, Museo della Cattedrale) al quale Alberti collabora probabilmente con consigli; per il Tempio malatestiano di Rimini disegni antichi (Firenze, Uffizi, e altre collezioni) che ne documentano le prime fasi e le successive, uno dei Portastemma dell’interno, opera di Agostino di Duccio o bottega, disegni dell’importante restauro del dopoguerra e un capitello antico figurato (Firenze, Museo archeologico nazionale) riconosciuto come possibile modello di quello straordinariamente impiegato da Alberti sulla facciata del Tempio; per palazzo Rucellai a Firenze uno degli importanti affreschi quattrocenteschi staccati dell’altana del palazzo (Collezione Rucellai), il tondo con lo stemma Rucellai già sul cortile del palazzo, e la straordinaria Urna del Beato Marcolino (Forlì, Pina coteca), scultura in marmo attribuita ad Antonio Rossellino, che qui replica la grande novità della facciata del palazzo, la combinazione di ordine e bugnato; per San Pancrazio a Firenze, disegni, capitelli antichi presi a modello da Alberti, e la Madonna con Bambino e santi di Giovanni di Piamonte (Città di Castello, Santa Maria delle Grazie); per San Sebastiano a Mantova, originali delle lettere di Ludovico Gonzaga e di Alberti per la costruzione della chiesa, il prezioso disegno del Labacco che ne documenta lo stato più vicino alla costruzione e altri disegni del XV e XVI secolo (Firenze, Uffizi), la Guarigione del ragazzo ferito da un toro, figlio di Nicola di Lorenzo da Prato (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria) che documenta l’immediata fortuna della mensola del portale della chiesa a fronte di una mensole attribuibile alla cerchia di Luca Fancelli (Museo di San Sebastiano, Mantova), e un inedito rilievo delle fondazioni della cripta; per Sant’Andrea a Mantova, numerosissimi disegni, pezzi antich i (Musei Capitolini, Roma; Museo archeologico nazionale, Roma) a fronte dei capitelli originali non più sulla facciata, il prezioso disegno di Vischer il Giovane che documenta l’ombrellone già nel 1515, e la nota veduta di Berlino (Technische Universität) della facciata nel XVIII secolo. Ma anche calchi antichi degli anticipatori bronzi di Donatello per l’altare del Santo a Padova, e due dipinti che testimoniano l’immediata fortuna della facciata albertiana fra la fine del secolo XV e il secolo XVI, la Figura eroica contro uno sfondo architettonico, di Fra’ Carnevale (proprietà Guido Cagnola) e la Veduta di città attribuita a Sebastiano Serlio (Ferrara, Pinacoteca Nazionale). Una mostra che vuole dunque presentare numerosissimi elementi che documentano una ricerca documentaria nuova, ma che non rinuncia a esporre opere capaci di seguire l’attività di Alberti architetto e la sua formazione. Dalla Padova, Venezia, Bologna e Firenze degli inizi, a Ferrara e Roma, e da qui a Rimini, Firenze e Mantova: anche com e architetto Alberti è un cosmopolita, e solo dopo la morte nel 1472, la pubblicazione a Firenze del De re aedificatoria sollecitata da Lorenzo il Magnifico (1485) lo ricondurrà in un alveo, quello degli umanisti e artisti fiorentini, che ad Alberti sarebbe parso limitativo e stretto.